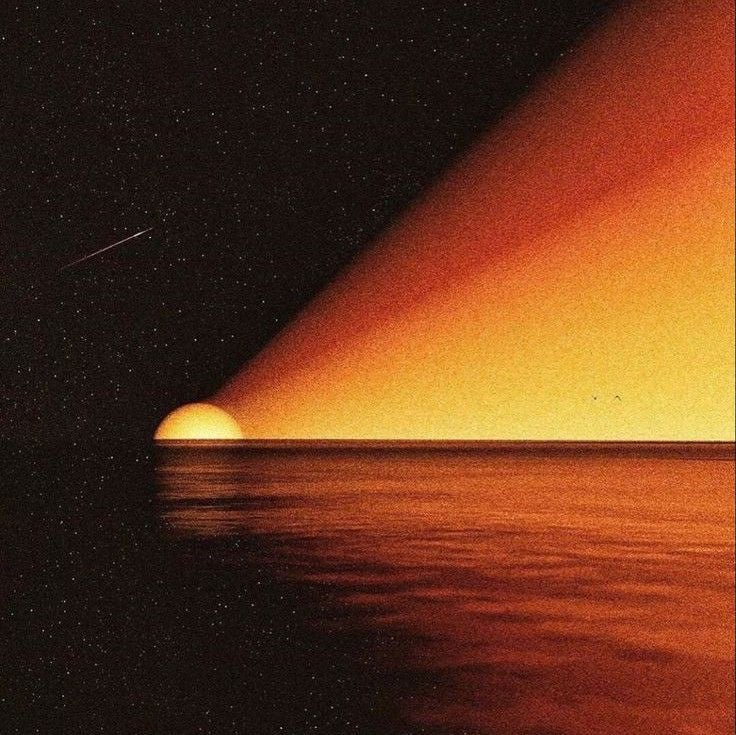Di Vincenzo Pellegrino
Il mondo contemporaneo si trova di fronte a una crisi profonda delle strutture di diritto internazionale ereditate dal dopoguerra, un sistema nato dall’esperienza westfaliana e consolidato dall’egemonia liberale statunitense, che oggi si rivela incapace di governare le dinamiche fluide e complesse di un’epoca multipolare, caratterizzata dall’ascesa di nuovi attori e da un incessante rimescolamento di alleanze. Tale trasformazione mette in discussione le fondamenta universalistiche dell’ordine globale, spingendo verso un ripensamento radicale che trova un fondamento teorico organico nelle visioni dei “grandi spazi” di Carl Schmitt e degli “Stati-civiltà” di Aleksandr Dugin, prospettive che abbandonano l’ideale di un’autorità mondiale omogenea per abbracciare un realismo politico capace di valorizzare la pluralità delle sfere di influenza e di riconoscere il conflitto come forza intrinseca alla politica.
Schmitt immaginava un mondo strutturato in grandi spazi geopolitici, ciascuno sotto l’egida di una potenza che ne definisce l’identità culturale e strategica, opponendosi a norme universali che, a suo giudizio, servivano solo a dissimulare gli interessi delle egemoni; la sua dicotomia amico-nemico radicava la sovranità in contesti concreti, una logica che oggi si manifesta nella tendenza delle potenze a ottimizzare il proprio raggio d’azione, focalizzandosi su aree prioritarie o cedendone altre, e che esige un diritto dinamico, modellato sulle specificità di ogni regione. Su questa base, Dugin elabora il concetto di “Stati-civiltà”, realtà che trascendono il modello dello Stato-nazione per ancorarsi a identità storiche, culturali e spirituali profonde – si pensi all’Eurasia russa o alla Cina confuciana – destinate a convivere in un equilibrio multipolare, svincolate da un paradigma dominante; questa visione getta luce su un’Europa segnata da crepe profonde, dove gli Stati nazionali riacquistano centralità mentre potenze come Stati Uniti, Russia e Cina ricalibrano le proprie strategie, aprendo per l’Italia la prospettiva di trasformare il Mediterraneo, da semplice confine, in un epicentro vitale, un nucleo geopolitico e culturale che ne ridefinisca il ruolo al di là delle dinamiche continentali.
Per l’Italia, questo passaggio non è un’opzione tra tante, ma un’esigenza imprescindibile, che si lega indissolubilmente alla necessità di rompere con l’Unione Europea, un’entità sempre più vissuta come una gabbia che ne soffoca le potenzialità e la confina a una subalternità cronica: l’UE, con il suo universalismo burocratico e il suo asservimento a logiche franco-tedesche o anglo-americane, strangola la vocazione mediterranea dell’Italia, condannandola a un’irrilevanza strategica e culturale che ne compromette la sopravvivenza. Liberarsi dall’UE significherebbe per l’Italia sottrarsi a un sistema che non offre protezione né sviluppo, riconquistando l’autonomia necessaria per plasmare il proprio destino in un mondo multipolare, sottraendosi alle fragilità di un continente in frantumi; un’uscita che implicherebbe certo il costo di perdere il mercato unico, ma che potrebbe essere compensata da partnership dirette con potenze come la Cina per investimenti infrastrutturali o con la Russia per accordi energetici: soluzioni fattibili che rilancerebbero l’Italia come attore sovrano nel Mediterraneo. Solo così potrebbe dar vita a un grande spazio mediterraneo, una realtà sovrana che, in sintonia con Schmitt, affermi la propria autodeterminazione geopolitica e, secondo Dugin, si nutra della sua identità civiltà, intrecciata alla storia e ai popoli del mare – un’identità che l’Italia potrebbe potenziare riscoprendo il suo universalismo di matrice romana, non come mera evocazione nostalgica, ma come capacità di irradiare un’influenza ordinatrice e inclusiva nel Mediterraneo, riprendendo quella missione civilizzatrice che la rese crocevia di popoli e culture.
Questo non è un gesto di chiusura, ma un atto di sopravvivenza: intrappolata tra le mire mitteleuropee della Germania e gli interessi atlantici di Francia e Regno Unito, l’Italia rischia di ridursi a strumento di forze esterne se resta incatenata a un progetto europeo che ne misconosce le esigenze vitali; svincolandosi, potrebbe invece riprendere il controllo delle sue risorse strategiche – dai porti di Trieste e Genova al potenziale industriale e militare – e intessere relazioni dirette con attori come Turchia, Russia o Stati Uniti, costruendo un blocco mediterraneo che la ponga al centro di una rete di influenze, anziché ai margini di un’Europa in declino. Tali relazioni potrebbero includere, ad esempio, un’alleanza con la Turchia per gestire le rotte migratorie, un costo dell’uscita dall’UE che troverebbe però una soluzione pratica nell’autonomia decisionale riconquistata.
Un diritto internazionale ridisegnato in questa chiave supererebbe le istituzioni sovranazionali, spesso ridotte a prolungamenti di egemonie al crepuscolo, per privilegiare accordi tra grandi spazi o Stati-civiltà, con norme che scaturiscono dal confronto tra realtà distinte piuttosto che da un’imposizione astratta; qui l’Italia potrebbe attingere al suo antico ius gentium, il diritto romano delle genti, che regolava i rapporti con i popoli stranieri non con un universalismo rigido, ma con un pragmatismo adattabile e inclusivo, offrendo un modello per un diritto mediterraneo moderno, capace di bilanciare specificità e cooperazione. Questo pluralismo comporta rischi, come la necessità di un equilibrio sottile per evitare scontri nelle aree di confine tra civiltà, dai Balcani al Medio Oriente, ma si fonda sull’imperativo della sopravvivenza, che per Schmitt e Dugin rappresenta il cuore della politica come capacità di garantire la continuità di una comunità nel tumulto della storia.
Ripensare il diritto internazionale attraverso i grandi spazi e gli Stati-civiltà significa accogliere la complessità del presente, riconoscendo che il potere si articola in forme plurali e che ogni entità politica deve poter perseguire i propri obiettivi essenziali; per l’Italia, ciò si concretizza in una nuova centralità mediterranea, una leva strategica che trasforma una vulnerabilità geografica in un’opportunità di autonomia, dove la sicurezza si fonde con una visione svincolata da schemi universalistici e radicata nella realtà di un mondo in trasformazione – un progetto che rende l’uscita dall’UE non solo una premessa ineludibile, ma il gesto decisivo per sfuggire a un sistema che ne soffoca l’identità e per reclamare un posto tra gli Stati-civiltà del futuro.