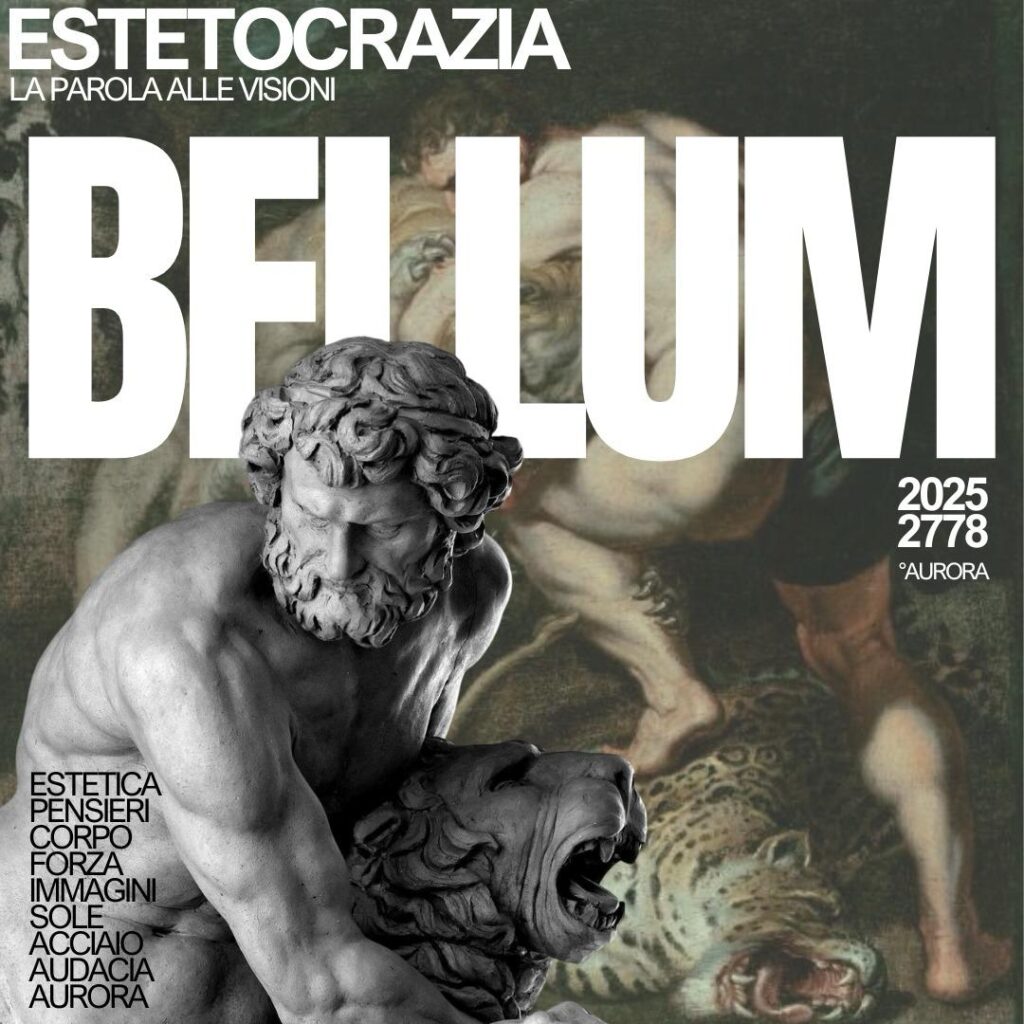Di Ludovico Feola
Quando si parla di “decisione”, che sia politica o meno, è necessario sapere con estrema lucidità e chiarezza qual è l’obiettivo, un obiettivo che deve rispondere essenzialmente a questioni vitali e di sopravvivenza. Lo stesso Mackinder scriveva che la prima istanza della politica è la fame.
Dunque, individuare un obiettivo e costruire una strategia globale che agisca in tutte le dimensioni che costituiscono la vita di un organismo avente carattere politico, nel nostro caso una nazione.
Questo assunto machiavellico si incastona nella dinamica amico-nemico, presente sia nell’anarchia del sistema politico internazionale, sia all’interno di un Paese, che abbia un grado di organizzazione elevato o meno.
Il senso di quanto scritto è per ribadire, anche se non dovrebbe essere necessario, che in un contesto globale fluido e dinamico, che ha vita dall’avvento di Trump al Campidoglio statunitense, è la strategia globale di una Nazione ad avere le proprie priorità, non quelle di un altro soggetto politico.
Se credete che vi siano delle forze che vincolino un pragmatismo e realismo politico che non siano la sopravvivenza, il mantenimento e l’incremento del potere, male; significa che siete stati soggetti a un lavoro di ingegneria politico-cognitiva o, più semplicemente, vi siete adagiati nel giardino della pace, dimenticandovi della guerra, perché la guerra è rapportata carnalmente alla politica.
Oggi, vediamo come la potenza egemone con declino relativo stia razionalizzando nella dimensione spaziale la sua irradiazione di potere. Coloro che credevano nel blocco occidentale, roccaforte dei valori liberali e democratici, nell’aprire un dialogo franco e diretto con una potenza revisionista come la Federazione Russa, sono rimasti sbalorditi. Invece, chi sa che il sistema gerarchico si muove in una dimensione di assenza di potere, non si stupisce affatto.
Trump dialoga con Putin, soprattutto per disimpegnarsi sul fronte europeo e delegarlo a un insieme di nazioni che presentano ancora una coesione del primo momento, ma che a breve deflagrerà. Da sottolineare, c’è una lettura semplicistica prodotta esclusivamente da analisti e giornalisti del Vecchio Continente, ovvero che vi sia una scelta strategica nel dialogo con Putin, volta ad allontanarlo dalla Cina, che rimane, soprattutto per il suo impegno nelle dinamiche marittime ed economiche, il primo competitor. Si crede ad un Kissinger 2.0, il che è estremamente riduttivo. Attuare una politica di azione periferica, classica delle politiche di stampo marittimo da Disraeli in poi, non è una scelta che sta attuando la nomenclatura USA. Sia Cina che Russia sono legate da un’alleanza inossidabile che ha fondamento sulla reciproca copertura di fronte alla potenza egemone.
Quindi, che politica sta attuando con Putin? Dalla configurazione di Tebe, Sparta, Atene, c’è molto da imparare. Trump lascerà alla Russia sfogare il suo dinamismo a Ovest, nell’Europa orientale, sia per aumentare la potenza che, comunque, rimane senza un diretto accesso sul mare, sia per incatenare il centro della storia, ovvero l’Europa, mettendola sotto pressione… inserendo però il germe del divide et impera.
Constatando che la qualità della classe dirigente europea ragiona tuttora con categorie ideologiche, si hanno problemi interni ed esterni per sostenere una political warfare che, sempre più probabilmente e velocemente, può tramutarsi in una guerra convenzionale.
La coesione europea, mantenuta dalla paura e da organizzazioni più o meno indipendenti come l’Unione Europea o la NATO (senza gli USA), sta vedendo un marasma di tensioni e dinamiche, come la lotta sotterranea tra Francia e UK per guidare la politica estera europea nei prossimi mesi, e per chi vorrà parteciparvi, con titubanza di Polonia e Italia, e paura dei Paesi Baltici, consapevoli di essere i prossimi oggetti di revisione russa, a partire da settembre 2025.
La Germania – unica nazione che, seppur con enormi problemi interni, fratture politiche e stato di deindustrializzazione quasi avanzato – è percepita, anche dalla Francia stessa, come l’unica capace, infrastrutturalmente e industrialmente, di procedere a un riarmo coatto e veloce, diventando la motrice dell’assetto eurocentrale.
Ma per il realista, ciò è solo l’anticamera di un periodo entropico che porterà all’assestarsi dei sistemi di alleanze, ognuna con partner diversi: una Germania volta alla Turchia e dunque alla Cina; una Francia legata agli Stati Uniti; e la massa danubiana-balcanica pronta a lacerarsi tra Germania e Russia.
E l’Italia? Ora l’Italia ricopre la posizione di testa di ponte per gli Stati Uniti, con cui mantiene ottimi rapporti, e un’intesa di dialogo diretto con UK e Francia. Ma il nostro apparato militare guarda alla Germania di Rheinmetall e alla Turchia; Iveco, Leonardo e Fincantieri gravitano intorno al porto di Trieste, invece di quello di Genova, a vocazione anglo-francese.
Nella storia ci sono moltissimi esempi in cui una potenza aggancia un soggetto politico al sistema di alleanze nemico, sia per mantenere un dialogo, sia per avere ingerenze nell’apparato tecnico-militare in preparazione di una guerra. In un certo senso, è stato fatto così anche con l’Italia, tra le due guerre mondiali, attuando poi, churchillianamente, una strategia periferica alle potenze dell’Asse, colpendo un’Italia fino a pochi anni prima amica.
Con questo si vuol dire che, anche dinanzi a un riarmo a trazione germanica, anche se complesso per la massima dipendenza europea dai sistemi di difesa statunitensi, dal calibro delle armi leggere ai codici di calibrazione dei sistemi anti-missilistici e ai nuovi, ingombranti e forse in futuro inutili F-35, con sistema operativo che risiede negli USA, la domanda sorge spontanea: Genova o Trieste?
Come in ogni nazione, impero o organizzazione politica, dinanzi alla tempesta della guerra, si creano essenzialmente due fazioni: chi la vuole scongiurare e chi spinge al riarmo. Indipendentemente dalla fazione di guerra in cui inserirsi, sempre per una motivazione realistica, subordinata alla necessità di sopravvivere.
Chi spinge per la pace con coloro che mirano alla guerra contro la nostra penisola va considerato come quinta colonna del nemico all’interno del paese. Chi parla di riarmo correlato a chi minaccia la nostra nazione è anch’egli una quinta colonna del nemico.
Riarmarsi, per avere una deterrenza e una sicurezza. Lo richiede la storia.