Di Paolo Mathlouthi
Giornalista di professione e scrittore itinerante per diletto, il fiorentino Paolo Ciampi sembra animato, ad una prima superficiale lettura delle sue gustosissime prose di viaggio, da un approccio smagato ed antiretorico verso i luoghi che di volta in volta si trova a dover attraversare. Partito alla volta della Romania sorretto dal sovrano intento di sfatare un luogo comune, quello che nell’immaginario simbolico occidentale associa il grande Paese carpatico al ricordo di Vlad l’Impalatore, leggendario condottiero consegnato ad imperitura gloria dal celeberrimo romanzo di Bram Stoker, la sua percezione orizzontale, osmotica ed inclusiva dell’idea di confine, s’infrange di colpo al limitare dell’immensa foresta che fa da corona alla Transilvania. Nel varcare la soglia di questa regione impervia, riposto scrigno di memorie ancestrali, l’Autore coglie con inequivocabile chiarezza come il limes possa tramutarsi in bastione, antemurale, e diventare giocoforza ancoraggio identitario. Attraverso il suo diario Non è il Paese di Dracula, dato alle stampe l’anno scorso per i tipi della Bottega Errante – casa editrice con sede a Udine particolarmente attenta nel registrare le mille voci, spesso neglette, di quelle che Claudio Magris ha definito a suo tempo le patrie carnali –, Paolo Ciampi ci offre, forse suo malgrado, l’opportunità di riannodare i fili dispersi della storia di una delle zone più contese del Vecchio Continente. Una vicenda sconosciuta anche ai lettori meglio attrezzati, che ha visto coinvolti altri scrittori, incamminatisi in epoche a noi prossime lungo il medesimo itinerario.
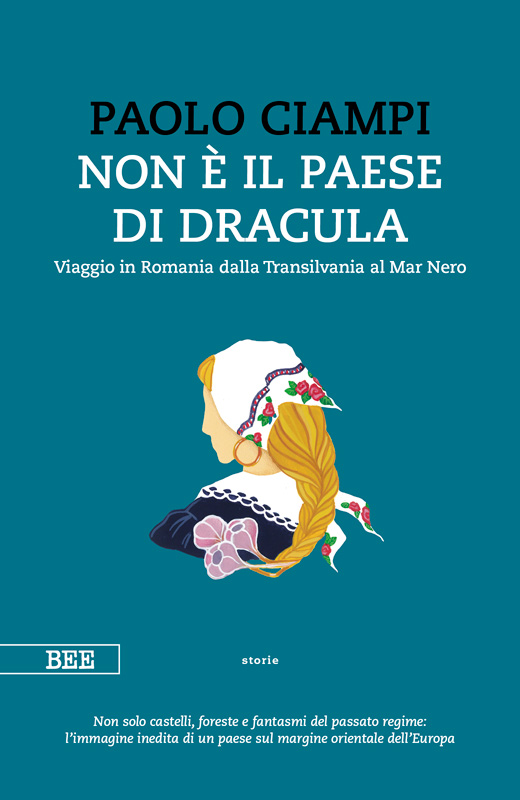
In base al trattato di Trianon, siglato il 4 giugno 1920, l’Ungheria, uscita sconfitta dalla Grande Guerra in quanto parte integrante della Duplice Monarchia austroungarica, si vede costretta a rinunciare a due terzi del suo territorio: la Transilvania, dove risiedono gli Székely, una comunità ungherese di quasi due milioni di persone insediatasi progressivamente a partire dalla fine del XII secolo, è ceduta alla vicina (e odiata) Romania. Nell’arbitraria opera di ridefinizione delle linee confinarie le Potenze vincitrici dell’Intesa perseguono una politica miope, per non dire scriteriata che, nel tentativo di imporre agli Imperi Centrali in dissoluzione obblighi volutamente umilianti, stravolgono il delicato equilibrio tra le diverse componenti etnico-religiose che animano l’area danubiano-balcanica, costringendole a convivenze forzate all’interno di territori spesso sovrappopolati e rinfocolando giocoforza odi atavici rimasti fino a quel momento sopiti grazie all’urgenza dettata dalle stringenti necessità del conflitto nonché all’indiscussa autorità morale di Francesco Giuseppe.
Lo scrittore inglese Patrick Leigh Fermor, che all’inizio degli snni Trenta attraversa a piedi l’Ungheria e la Romania diretto alla volta di Istanbul, scelto non a caso da Paolo Ciampi quale ideale compagno di viaggio, nelle sue prose itineranti, ripubblicate da Adelphi, registra in presa diretta, dalla viva voce dei protagonisti, lo smarrimento e la frustrazione che attanagliano i proprietari terrieri ungheresi residenti in Transilvania, espropriati delle tenute a vite in favore dei loro contadini di origine rumena, diventati all’improvviso i nuovi padroni: “Pressoché tutti i possidenti – scrive – erano stati costretti dalle circostanze a prendere la cittadinanza rumena, ma pochissimi erano mai capitati a Bucarest. La consideravano una distante Babilonia di sporcizia, malaffare e perversione e giuravano che se fosse stato per loro non vi avrebbero mai messo piede, e addirittura non avrebbero mai attraversato quello che era stato il confine orientale della loro patria. Struggendosi di desiderio per la corona di Santo Stefano, non avevano né occhi né orecchie né cuore per nient’altro che il loro mutilato regno a occidente […]. Circondati come un’isola dalla rustica moltitudine rumena, diversi per razza e religione e con i fantasmi della perduta supremazia che ancora aleggiavano, l’atmosfera dominante che avvolgeva gli abitanti dei kastélyok richiamava quella delle cadenti proprietà degli anglo-irlandesi intorno a Waterford o a Galway, con tutta la loro tristezza e il loro incanto. Nostalgici del passato, senza altre frequentazioni se non i loro simili […], gli Ungheresi della Transilvania vivevano in un sogno retrospettivo, genealogico, quasi confuciano […]. Benché tutti, laggiù, la sapessero lunghissima sulla storia dell’Europa centrale, le loro conoscenze si arrestavano di colpo sulla cresta dei Carpazi. La storia della Romania […] esulava dal loro campo di interesse e veniva invariabilmente liquidata con brevi accenni alla wilde Walachei, la “selvaggia Valacchia”, neanche si trovasse nel cuore della steppa mongola”.
Un mosaico maledettamente intricato, quello rumeno, che si aggroviglia ulteriormente quando l’Ammiraglio Horthy, dopo aver rovesciato la fragile Repubblica dei Consigli instaurata da Bela Kun nell’immediato primo dopoguerra, reclama la corona di Santo Stefano assumendo i pieni poteri in qualità di Reggente per conto degli Asburgo-Lorena (in vista, quindi, di un’improbabile restaurazione dell’Impero) e denuncia a gran voce nelle opportune sedi diplomatiche il carattere iniquo e unilaterale del trattato di Trianon, sostenendo che la Transilvania non può in alcun modo essere considerata terra rumena in quanto, all’atto della riunificazione dei Principati danubiani sancita da Alexandru Cuza nel 1866, quest’ultima non figura tra le terre facenti parte del nucleo storico originario del costituendo Stato nazionale carpatico. Esclusione ratificata peraltro anche dal congresso di Berlino del 1878, durante il quale Bismarck accorda a Carlo I Hohenzollern il titolo di Re di Romania per ricompensarlo del contributo offerto ai Romanov nella guerra contro la Sublime Porta, limitando nondimeno la giurisdizione della sua sovranità soltanto alla Moldavia e alla Valacchia, riconoscendo per contro le pretese dell’Ungheria sull’area contesa.
L’abile colpo di mano messo a segno all’indomani dell’armistizio dall’esercito rumeno, che si attesta sulle sponde del fiume Mures annettendo manu militari la regione alla Romania, viene considerato da Budapest come un atto proditorio, finalizzato a forzare la mano ai delegati riuniti a Parigi per i lavori della conferenza di pace, mettendoli di fronte al fatto compiuto. Nello sforzo profuso in vista della revisione del trattato, Horthy trova un insospettabile alleato in Benito Mussolini. Il Fascismo, impegnato in una sua peculiare Ostpolitik, sostiene infatti con forza le rivendicazioni dell’Ungheria sulla Transilvania in quanto curiosamente speculari alle rimostranze avanzate dal nostro governo circa il mancato riconoscimento delle pretese italiane sull’Istria e sulla Dalmazia. Si inserisce in questa cornice la missione culturale e diplomatica compiuta in Transilvania sul finire degli anni Venti per conto del prestigioso Istituto di Studi sull’Europa Orientale di gentiliana memoria da parte di uno scrittore italiano dimenticato, Gino Cucchetti (1881-1972), strappato di recente all’oblio dalla casa editrice milanese Iduna.
Critico letterario che nel periodo tra le due guerre si è conquistato una certa fama con i suoi saggi, scrittore e versatile giornalista politico con il pallino delle questioni internazionali, accetta l’invito di Luigi Zambra, all’epoca titolare della cattedra di Letteratura italiana presso l’Università di Budapest, a recarsi nella patria di Dracula per tenere un ciclo di conferenze e poter prendere contatto in prima persona con la complessa e variegata realtà danubiana. Temperamento romantico con il dono di un eloquio veemente che strappa ovunque ovazioni, il poliedrico polemista sposa una ragazza del posto, la celebre pittrice e scultrice Sasha Robb scomparsa nel 2001, aderisce alla Lega per la revisione del trattato di Trianon e partecipa alle sanguinose sollevazioni di piazza scoppiate nel 1931 in seguito all’assalto condotto dai nazionalisti rumeni della Guardia di Ferro contro il consolato di Cluj Napoca /Kolozsvar in occasione dell’anniversario della controversa annessione della Transilvania alla Romania. A lui si deve l’idea, accolta di buon grado dal suo mentore e avallata dalle autorità littorie, di costituire a Budapest un Istituto di Cultura Italiana che ha saputo resistere alle ingiurie del tempo ed è tuttora operante.
Oggi che i politici dell’Unione Europea, orfana di punti di riferimento ideali e coordinate strategiche, discettano senza costrutto del Manifesto di Ventotene, la Transilvania, più che mai pomo della discordia, esattamente come il Donbass, la Transnistria e le numerose altre regioni storiche che punteggiano il Vecchio Continente, è ancora lì a dimostrare alle anime candide quanto il passato non si rassegni di buon grado ad essere tale. Al vociare cupo e rancoroso del proletariato deluso dalle false promesse della globalizzazione che monta per le strade di Budapest come un’onda anomala e accompagna il passo cadenzato della Magyar Garda, formazione paramilitare che in file ordinate e disciplinatissime innalza inni alla Grande Ungheria e alla Transilvania irredenta, tema caldo sul quale prima Gabor Vona e poi Viktor Orban hanno fatto leva a più riprese per mietere consensi, fanno eco le giaculatorie del clero ortodosso rumeno che tra le volte affrescate della Cattedrale della Santissima Trinità a Sibiu leva al cielo vieti canti legionari, evocando lo spettro mai placato di Corneliu Zelea Codreanu. Le anonime architetture amministrative di Bruxelles e Strasburgo sono, in tutta evidenza, lontanissime dal cuore tumultuoso dell’Europa.
Paolo Ciampi, Non è il Paese di Dracula, Bottega Errante Edizioni, Udine 2024; pag 160 € 17,00




